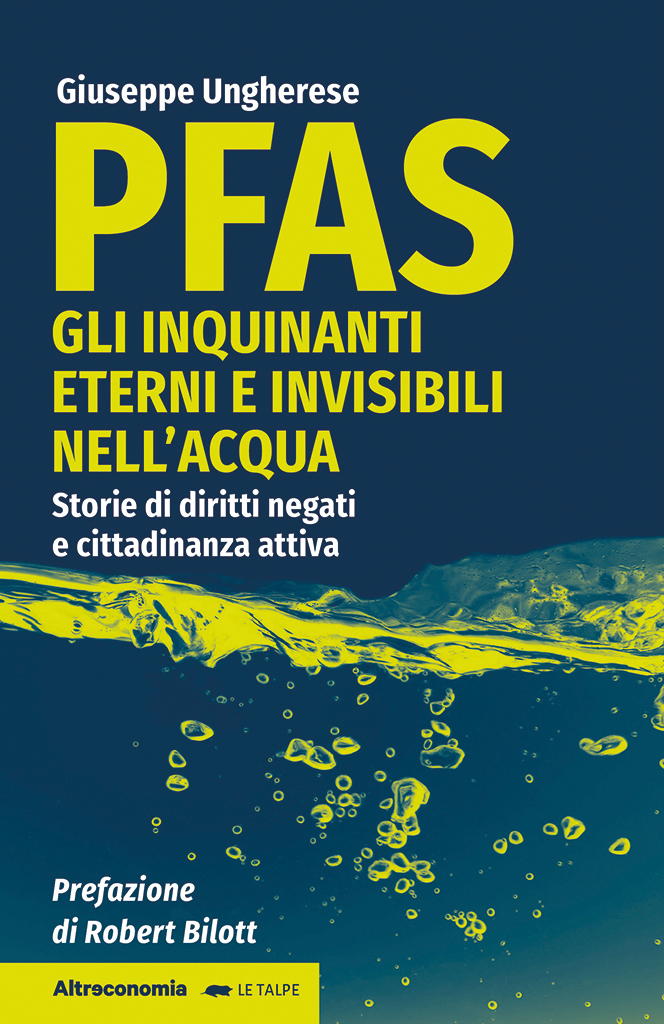Ambiente / Attualità
L’Italia ai piedi delle grandi dighe. Tra vetustà, sicurezza e futuro

L’età media dei più importanti sbarramenti nel nostro Paese è di 62 anni, e manca un censimento dettagliato di quelli più piccoli, almeno 12mila, sotto l’egida delle Regioni. L’ipotesi “dismissione” pone seri interrogativi. Ecco perché
La sciagura avvenne a metà luglio. I bacini di decantazione della miniera di fluorite del monte Prestavel, in Val di Stava, Trentino-Alto Adige, ruppero gli argini e scaricarono 180mila metri cubi di acqua e fango sull’abitato, causando 268 morti. Gli argini in terra erano stati costruiti senza rispettare i coefficienti di sicurezza. Era il 1985. “Non si trattava di una grande diga -ricorda Renzo Rosso, professore ordinario di Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia al Politecnico di Milano- bensì il rilevato arginale di un piccolo serbatoio montano a uso industriale”. Ma fu solo dopo quel disastro, spiega Rosso, che venne “introdotta la prima prescrizione in materia a fini di protezione civile” e “ci si accorse che nel territorio italiano esistevano anche le piccole dighe”. Partì “un censimento dei piccoli invasi artificiali sia tramite telerilevamento sia con ricognizioni sul terreno” e il risultato fu di 8.288 “piccoli invasi” e 555 “grandi dighe”.
Trent’anni dopo, l’Italia si ritrova a fare i conti con la vetustà delle dighe, grandi o piccole che siano, e con la dismissione di alcune. Pochi giorni dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, il 14 agosto 2018, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli annunciò infatti che “a stretto giro” sarebbe stata inviata “a tutti gli enti e soggetti gestori di strade, autostrade e dighe una comunicazione formale in cui si chiede che entro il primo settembre 2018 vengano segnalati al ministero tutti gli interventi necessari a rimuovere condizioni di rischio riscontrate sulle infrastrutture di propria competenza, corredando le relative segnalazioni di adeguate attestazioni tecniche e indicazioni di priorità”. Tre mesi dopo, però, il Mit non è stato in grado di fornire un aggiornamento dettagliato. Per comprendere il contesto, quindi, è utile rifarsi ai dati pubblicati nell’ultimo “Conto nazionale delle Infrastrutture e dei trasporti” a cura dell’ufficio statistico del Mit. Al mese di marzo di quest’anno, gli invasi più rilevanti, quelli creati dalle cosiddette “grandi dighe”, alti più di 15 metri o con un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, erano 533, per un “volume totale di invaso dei serbatoi” pari a 13,7 miliardi di metri cubi. Qualche esempio: la diga del Vajont (concessionario Enel) o del Lumiei (A2a) in Friuli-Venezia Giulia, dell’Alpe Gera (Enel) o di Frera (Edison) in Lombardia. La loro vigilanza spetta allo Stato, mentre al di sotto della soglia dei 15 metri o del milione di metri cubi di invaso (le “piccole”), la responsabilità è in capo alle Regioni.
Non tutte le 533 “grandi dighe”, però, risultano in esercizio. Quelle attive nel 2018 “senza condizioni” e in concessione sono infatti 382. Dopodiché ne esistono 32 “in esercizio limitato per motivi tecnici”, 81 “in esercizio sperimentale”, 11 “in costruzione o con lavori di costruzione conclusi ma con invasi sperimentali non avviati” e 27 fuori esercizio “per motivi tecnici”. Dunque, sempre secondo il ministero, tra “esercizio condizionato” e “non in esercizio” stiamo parlando di 151 impianti. Quando funzionano, per usare le parole del professor Rosso, autore del recente saggio “Bombe d’acqua” (Marsilio, 2017), le grandi dighe sono un “polmone” impiegato per finalità diverse. “Per il 61% dei casi a scopo idroelettrico, il 26% a uso irriguo e il 12% per l’approvvigionamento idropotabile, anche se l’ultimo dato è sottostimato, in quanto l’opera di presa delle dighe non è sempre censita”.
12mila (circa) il numero minimo stimato di piccole dighe sparse su tutto il territorio nazionale
Per riconoscere l’utilità di una “grande diga” è necessario un attento calcolo “costi/benefici”. Lo sa bene Andrea Goltara, ingegnere e direttore del Centro italiano per la riqualificazione fluviale (Cirf, cirf.org). “I grandi invasi hanno indubbiamente un impatto ecologico molto elevato sui corsi d’acqua: interrompono la continuità per la fauna ittica (in mancanza di questa si può arrivare fino all’estinzione della specie, come successo anche in Italia) e per il trasporto dei sedimenti, da cui deriva un’alterazione fisica su larga scala; tipicamente, poi, turbinando solo in corrispondenza dei picchi di domanda energetica, creano un’alterazione delle portate a scala oraria con effetti devastanti sugli organismi acquatici”. Un impatto pesante a fronte però di un ruolo che talvolta può essere strategico. “Sia perché questi impianti possono concentrare nel tempo, quando più è utile, la produzione -riflette Goltara-, sia perché possono, se adeguatamente gestiti ed entro certi limiti, avere un ruolo di mitigazione dei picchi di piena e di regolazione delle portate nei momenti critici”. Da qui la complessità dello sguardo. Ma quando parliamo di dighe “ammalorate” allora porsi il quesito sul “che farne” è fondamentale. “In molti Paesi si è iniziato da tempo a ragionare sull’opportunità di rimuovere alcune dighe e sbarramenti, a partire da quelle che sono a rischio e che potrebbero cadere da sole -sintetizza Goltara-. Ci sono dighe che cominciano ad avere problemi strutturali? Bene, iniziamo a valutare se conviene svuotarle, abbatterle, rifarle, aggiustarle”. Altrove già succede, seppur più nei casi di piccoli sbarramenti che per grandi dighe (si pensi ad esempio alle iniziative del movimento “Dam removal”, damremoval.eu).

L’importante, in ogni caso, è tenere conto di aspetti storicamente trascurati. Goltara ne elenca alcuni. “Penso ad esempio alla continuità del trasporto solido, soprattutto quello grossolano, che è quello che mantiene e fa evolvere nel tempo la forma del fiume. Se manca, come succede spesso a valle delle dighe, l’alveo si incide, creando impatti ambientali e danni ingenti alle infrastrutture, oltre a molti altri ‘effetti collaterali’, sulle falde acquifere, sulla vegetazione riparia, sugli usi dell’acqua a valle”.
È l’età media dei grandi invasi a suggerire di fare queste valutazioni per tempo. Dai 70 anni delle Regioni dell’arco alpino e dell’Appennino ligure e tosco-emiliano ai 45 scarsi del Sud. La media nazionale è di 62 anni. Si tratta di colossi immaginati in tempi lontanissimi, quando cioè “gli scarichi di sicurezza furono progettati e costruiti quando l’idrologia era ancora considerata un’arte e non una scienza. Quando le valli erano poco abitate e la presenza delle dighe non aveva ancora favorito il senso di falsa sicurezza che ne ha indirizzato la colonizzazione”, aggiunge l’autore di “Bombe d’acqua”. Non a caso, nell’ultimo Conto nazionale del ministero delle Infrastrutture sono riportati 77 interventi “necessari per la manutenzione straordinaria e le rivalutazioni sismiche” sulle dighe. Ecco perché Rosso lega la loro “vetustà” a “seri interrogativi in materia di sicurezza, in primo luogo sismica e idraulica”.
“Nonostante la dimensione modesta, le piccole dighe pongono aspetti tecnici non indifferenti e problematiche massime per la sicurezza” – Comitato grandi dighe
Per poter “evitare rimorsi”, il professore mette in guardia -da tempo- circa la reale “capacità di controllo dell’ente pubblico”, dato anche “l’annientamento degli organi tecnici, operato in modo scientifico in questo inizio di secolo”. Si riferisce ad esempio alla scomparsa prematura del Registro italiano dighe -istituito nel 1998- rimpiazzato poco dopo dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche in seno al Mit. Ma non è una questione che si esaurisce nelle “grandi”. Accanto a loro, infatti, c’è la platea sterminata delle “piccole”, di sfera regionale. E di queste non esiste nemmeno un censimento aggiornato ma solo una stima datata 2017 del Comitato italiano grandi dighe (ITCOLD, itcold.it). Rispetto al 2009-2010, l’incremento è stato del 60%. Da circa 8.200 unità si sarebbe passati a un “ordine di 12.000-14.000 su tutto il territorio nazionale”, come si legge nel rapporto “Le piccole dighe in Italia”. Il gruppo di ricerca del Comitato ha “esaminato la situazione delle varie normative regionali esistenti, riscontrando una evidente incompletezza ed eterogeneità”. Appena 11 Regioni (e le Province a statuto speciale di Trento e Bolzano) avrebbero infatti “emesso documenti normativi afferenti gli sbarramenti di competenza regionale”, presentando tra loro “importanti eterogeneità e differenziazioni”. L’errore è pensare che “piccola” voglia dire ininfluente. “Nonostante la dimensione modesta -spiegano dal Comitato-, le piccole dighe pongono aspetti tecnici non indifferenti e, alla luce del loro ingente numero (di non irrilevante importanza), problematiche massime per la sicurezza”. Basti pensare al disastro dell’abitato di Stava. Quegli invasi per il “deposito, decantazione e lavaggio di minerali o residui industriali”, ai tempi della catastrofe, “erano di competenza del Genio minerario e del ministero dell’Industria”, si legge nel report. E 33 anni dopo? “Successivamente dovrebbero essere passati al ministero dell’Economia”. Ma “non si conosce a che struttura tecnica facciano attualmente riferimento”.
La Valle d’Aosta è stata tra le poche a rispondere alla nostra richiesta di “check-up” delle dighe e degli sbarramenti sul proprio territorio, che in totale sono 81. “Vengono utilizzati prevalentemente a scopo idroelettrico (69), anche se negli ultimi anni sono stati costruite alcune dighe in materiale sciolto per la produzione di neve programmata (10)”, spiegano dall’Ufficio dighe. Su dieci concessioni di sbarramenti idroelettrici regionali, sette fanno capo alla C.V.A. Spa, con scadenza fissata al 31 marzo 2029. E l’età media degli impianti “piccoli” in questa Regione è di 57 anni, con oltre un quarto costruiti tra 1900 e 1925.
Oltre agli impatti, alla vetustà e alla sicurezza, Renzo Rosso aggiunge un altro elemento importante che riguarda le dighe: la loro dismissione. “Sono a conoscenza del fatto che alcuni concessionari, per ragioni strettamente economiche e di costi di gestione, sono intenzionati a ‘restituire’ la concessione, ormai non più conveniente, e che quel grande invaso non venga quindi più gestito. Non è possibile abbandonarlo quanto semmai renderlo ‘trasparente’, determinando così di nuovo piene naturali. Se però nel frattempo è cambiata una parte consistente della geometria idraulica delle valli sottostanti, perché magari si è costruito lungo gli argini o ristretto i corsi d’acqua, che cosa succederà?”. La dismissione non è un fenomeno isolato: stando a Rosso, interesserebbe quasi un quarto delle grandi dighe. E i dati Ispra sul consumo del suolo a danno dei corpi idrici sono sconfortanti. “Il livello di impermeabilizzazione entro la fascia di tutela dei 150 metri dai corpi idrici raggiunge nel 2017 livelli molto elevati in Liguria (circa il 21% di tale superficie è coperta artificialmente), Valle d’Aosta (15,4%) e Trentino-Alto Adige (13,4%), rispetto ad una media nazionale del 7,6%, con un incremento sul 2016 dello 0,25%”, ricorda Michele Munafò, del dipartimento per il Servizio geologico d’Italia dell’Ispra e curatore del Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” dell’Istituto (isprambiente.gov.it). Tradotto: solo nel periodo 2016-2017, in Italia, sono stati consumati 104 ettari di suolo entro i 150 metri di distanza dai fiumi. Il monito di Rosso rischia di essere travolto.
© riproduzione riservata