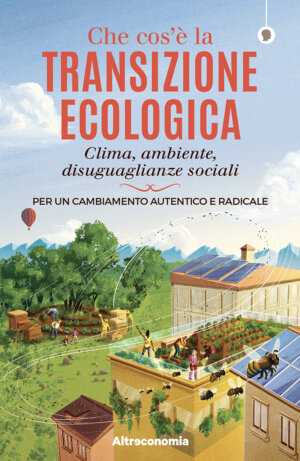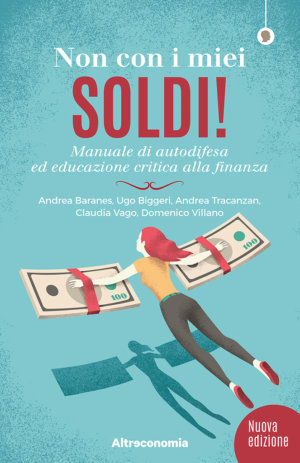Economia / Approfondimento
Dall’energia alla finanza: cambiare modello per costruire davvero un’economia di pace

I combustibili fossili e la nostra dipendenza non sono le uniche “radici” che accomunano la guerra di Putin all’emergenza climatica planetaria. Anche il settore finanziario gioca un ruolo decisivo. Ecco perché è necessario un cambiamento
“Se non riusciamo a porre fine all’era dei combustibili fossili nemmeno di fronte al massacro dei civili e alla distruzione del nostro Pianeta, che cosa ci vorrà allora?”. Il 10 marzo, dalle colonne del Guardian, l’economista ucraino Oleg Ustenko ha rivolto la domanda a quei “leader del mondo”, in particolare europei, “intimoriti dalla messa al bando del petrolio russo”. Greggio “insanguinato”, l’ha definito Ustenko, paragonandolo ai diamanti contrabbandati tra Sierra Leone e Liberia.
Il regime di Vladimir Putin, infatti, ha incassato nel 2021 qualcosa come 285 milioni di dollari al giorno solo dall’export di greggio, petrolio e diesel nei Paesi dell’Unione europea: 104 miliardi di dollari in un anno. Il gas, posto di più sotto i riflettori, non arriva alla metà del valore (100 milioni di dollari al giorno, 43,4 miliardi all’anno). L’aggressione militare ai danni dell’Ucraina trae quindi linfa vitale dalla vendita di combustibili fossili, pari al 36% dell’intero budget della Federazione russa dello scorso anno. Ecco perché Ustenko ha chiamato in causa direttamente i capi di governo di Germania, Regno Unito e anche dell’Italia. Senza ricevere una risposta chiara. “La soluzione non può essere semplicemente sostituire il petrolio russo con quello saudita”, chiarisce però William Todts, direttore esecutivo della Federazione europea per il trasporto e l’ambiente (Transport & Environment).

È il momento di cambiare modello, dall’energia alla finanza, per costruire davvero un’economia di pace. Gli interessi sono enormi quanto l’ipocrisia. È il caso della multinazionale fossile Shell: a inizio marzo, mentre i civili inermi di Irpin o di Mariupol venivano presi di mira dall’esercito di Putin, così come gli ospedali pediatrici, il colosso anglo-olandese acquistava un carico di 100mila tonnellate di petrolio russo approfittando di un prezzo di saldo di appena 30 dollari al barile. Smascherato, dal Wall Street Journal, è dovuto correre ai ripari, annunciando lo stop agli acquisti di greggio e gas. Solo dalla Russia.
L’italiana Eni nicchia: al 15 marzo 2022 non aveva bloccato i contratti di acquisto in essere di gas e petrolio. Interpellata da Altreconomia, Eni ha fatto sapere di “monitorare l’evoluzione della crisi internazionale” ed essere pronta a rispettare “pienamente quanto eventualmente verrà deciso dalle istituzioni italiane ed europee”. Sui prodotti petroliferi ha poi dichiarato di aver “sospeso la stipula di nuovi contratti relativi all’approvvigionamento di greggio dalla Russia” ma “rimangono in essere i contratti di fornitura stipulati prima della crisi, che includono carichi rispetto ai quali Eni sta tuttavia svolgendo, caso per caso, le opportune valutazioni in termini commerciali e di logistica”.
Nel 2021 il 18% dei greggi lavorati da Eni è stato di provenienza russa e l’azienda vorrebbe “sostituire le quote ricorrendo al mercato internazionale, considerando l’ampia flessibilità di lavorazione delle raffinerie Eni e l’ampia qualità dei greggi lavorabili”. Sul gas, a parte l’annunciata intenzione di “procedere alla cessione della propria quota di partecipazione congiunta e paritaria con Gazprom nel gasdotto Blue Stream” (che collega la Russia alla Turchia attraverso il Mar Nero), è calma piatta, con non poco imbarazzo. Neanche un anno fa, infatti, la multinazionale guidata da Claudio Descalzi annunciava i “maggiori volumi di gas approvvigionati in Russia”: dai 10,25 miliardi di metri cubi del primo semestre 2020 ai 13,79 miliardi dell’analogo periodo 2021 (più 34,5%), oltre un terzo del totale in quota estero, staccando Algeria, Norvegia e Qatar. Questi ultimi sono i candidati di Eni -e del governo Draghi- a surrogare Mosca.

Secondo il think tank indipendente Carbon Tracker, la brutale aggressione dell’Ucraina ha sì evidenziato l’urgenza per l’Europa di svincolarsi dalla dipendenza energetica verso la Russia, accelerando la già ritardata transizione ecologica, ma legarsi nel medio periodo ai combustibili fossili “non ha senso, a prescindere da dove questi arrivino”. Anche gli invocati giacimenti “autoctoni” sono una risposta sbagliata e controproducente: “Come abbiamo evidenziato nel nostro recente rapporto sul gas ‘Put gas on standby’ -spiegano da Carbon Tracker-, la stragrande maggioranza degli impianti a gas pianificati oggi in Europa sono incompatibili con un percorso di emissioni nette zero e rischiano di far perdere miliardi agli investitori e ai contribuenti, legando gli utenti finali a prezzi energetici volatili e costosi”.
La pressione dell’industria fossile però è fortissima e non solo in Europa. Negli Stati Uniti, ad esempio, dieci giorni prima dell’inizio della guerra, Mike Sommers, amministratore delegato dell’organizzazione lobbistica American petroleum institute, promuoveva su Fox l’“indipendenza energetica” degli Usa, attaccando le voci contrarie alla devastante trivellazione dell’area naturale protetta dell’Arctic national wildlife refuge in Alaska o tentando di riabilitare il sistema di oleodotti Keystone pipeline system tra Canada e Stati Uniti. E lo stesso Sommers, in compagnia del Natural Gas Council, firmava in quelle stesse ore una (incredibile) lettera aperta al presidente Joe Biden dove era rigettata la “falsa scelta tra lo sviluppo delle abbondanti risorse di gas naturale dell’America e il raggiungimento dei nostri obiettivi climatici”.

“Nonostante la guerra di Putin sia pagata con petrodollari, la soluzione sembra ancora trivellare, estrarre petrolio e gas con il fracking e poi spedirli via nave: non importano i costi per il nostro Pianeta o per il nostro futuro”, ha notato con amarezza Naomi Klein, giornalista e corrispondente del sito d’inchiesta The Intercept nonché autrice dell’attualissimo “No logo” (1999). Con un paradosso: le nuove centrali a gas o i reattori nucleari alimentati da combustibili a marchio Russia -che è pure tra i primi produttori di uranio arricchito al mondo- potrebbero ricevere la garanzia di investimenti finanziari sostenibili grazie alla “tassonomia” proposta dalla Commissione europea il 2 febbraio 2022.
Per bloccare il macroscopico greenwashing, oltre 90 organizzazioni della società civile hanno lanciato un appello il 10 marzo rivolto alle istituzioni finanziarie chiedendo loro di impegnarsi pubblicamente a escludere gas e nucleare dai propri prodotti d’investimento o bond “green”. Lanciando l’iniziativa, Paul Schreiber, attivista della Ong Reclaim Finance è stato piuttosto lapidario: “La guerra all’Ucraina getta una nuova luce sul disastro della tassonomia dell’Unione europea. I Paesi democratici devono ridurre rapidamente la loro dipendenza dai combustibili fossili e dai produttori autoritari come la Russia, rispettando i loro stessi impegni sul clima. Tuttavia la decisione dell’Ue di bollare il gas fossile come sostenibile apre la strada a una rinnovata dipendenza e offre credenziali verdi ai suoi produttori”. Cioè l’esatto opposto di quel che è necessario.

Come detto non è “solo” il gas a legare l’Unione europea alla Russia (per il 40% dei consumi nel 2021). C’è soprattutto un fiume di petrolio che vale tre volte i guadagni di Mosca sul metano. Nel 2020 l’Ue dipendeva dalle importazioni per il 95,9% del suo approvvigionamento di petrolio greggio. Un quarto di queste arrivava dalla Russia, pari a 113 milioni di tonnellate (fonte Eurostat), prevalentemente via mare e, in minima parte, attraverso gli oleodotti. È interessante notare come il flusso Russia-Ue di petrolio sia cresciuto tra 2014 e 2016, con buona pace della “crisi” in Crimea e della sua successiva annessione a Mosca. Allora si era meno solidali con la libertà ucraina. Germania, Polonia, Olanda, Finlandia, Belgio, Lituania, Slovacchia e Italia sono i Paesi che hanno importato più greggio russo nel 2020.

I principali porti russi di partenza dei barili di petrolio -oltre due milioni al giorno, in media- sono quelli di Primorsk e Ust-Luga sul Mar Baltico e di Novorossiysk sul Mar Nero. Il resto raggiunge le raffinerie europee attraverso i 4mila chilometri del condotto di Druzhba (che significa “amicizia”). I primi dieci porti europei di destinazione assorbono il 51% del traffico di greggio russo in entrata: guida la classifica Rotterdam, staccando Gdansk (Polonia), Trieste, Le Havre, Marsiglia, Genova, Tarragona, Sines (Portogallo), Bilbao e Immingham (Regno Unito). “Visto che l’Ue è il più grande importatore di petrolio russo abbiamo cercato di vedere se c’era una correlazione tra questo mercato e le spese militari di Mosca”, spiega Thomas Earl di Transport & Environment. Incrociando i dati dell’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (Sipri, sipri.org) e di GlobalSecurity hanno ottenuto dettagli qualitativi interessanti. “Correlazione non significa causa-effetto -premette Earl- ma è oggettivo che il bilancio del ministero della Difesa russo sia legato al petrolio. Data la costante e affidabile domanda di greggio da parte dell’Ue è chiaro che questa abbia contribuito in modo determinante alla modernizzazione dell’esercito russo”.

I combustibili fossili e la nostra dipendenza non solo le uniche “radici” che accomunano la guerra di Putin all’emergenza climatica planetaria, come ha saggiamente sottolineato la scienziata ucraina Svitlana Krakovska, impegnata nel National antarctic scientific center di Kiev, nell’Ukrainian hydrometeorological institute e nel Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (Ipcc). Anche il settore finanziario sta infatti giocando un ruolo chiave. Il 3 marzo Reclaim Finance ha lanciato una campagna internazionale per mappare i “Putin 100”, cioè i primi cento gruppi finanziari del mondo maggiormente esposti verso la Russia o affari fossili connessi.
I primi destinatari della lettera aperta della coalizione di Ong sono stati AIG, Allianz, Atradius Re, AXA, Chubb, General Re, Hannover Re, Lloyd’s, Munich Re, Partner Re, SCOR, Swiss Re, Tokio Marine, Travelers, Zurich, Aviva Investors, Bank of America, BlackRock, BPCE/Natixis, Carmignac Gestion, Citi, Commerzbank, Crédit Agricole, Credit Suisse Group, DekaBank Deutsche Girozentrale, Deutsche Bank, Erste Group Bank, Fidelity International, FMR LLC, Goldman Sachs Group, Industrial and Commercial Bank of China, ING Group, Intesa Sanpaolo, Invesco Ltd, JPMorgan Chase, Legal & General Group, M&G, Mizuho, Morgan Stanley, MUFG, Pictet Funds, Prudential Financial, Raiffeisen Banking Group, Schroders, SMBC Group, Société Générale, State Street Corp, UBS, UniCredit, Vanguard Group.
Nell’incipit le organizzazioni hanno citato Desmond Tutu, il grande arcivescovo anglicano e attivista sudafricano scomparso il 26 dicembre 2021. “Scegliere la neutralità di fronte all’ingiustizia equivale a scegliere la parte dell’oppressore”, con tanto di invito perentorio a togliere qualsiasi sostegno alle aziende che “stanno contribuendo ad alimentare direttamente la guerra della Russia in Ucraina”. “Il ruolo della finanza, intesa come banche e società finanziarie, è fondamentale -riflette Andrea Baranes, presidente della Fondazione Finanza Etica e componente del board del network europeo Finance Watch-. Indirizza il denaro che alimenta l’economia, quindi alimenta un modello. O un altro”.

Il sistema finanziario ha un’altra responsabilità: quella di aver fiaccato i tentativi di identificare, tracciare e sequestrare gli asset riferibili a società o persone fisiche legate alla Federazione russa (i riscoperti “oligarchi”, coccolati fino a ieri dall’informazione mainstream per le squadre di calcio, gli yacht griffati Philippe Starck o le ville da capogiro). “Abbiamo trascorso decadi a corteggiare ricchi dittatori, evasori fiscali e organizzazioni criminali, garantendo loro il segreto bancario, regole ‘bendate’ e l’anonimato. Tutto questo ha reso praticamente impossibile per i governi tenere traccia dei patrimoni”, ha ricordato a marzo Tax Justice Network (Tjn), che da lungo tempo si batte per la giustizia fiscale. La riforma strutturale del sistema finanziario globale è urgente: ogni anno 483 miliardi di dollari finiscono nei paradisi fiscali, sottratti alle casse dei Paesi. Offshore è stimata una ricchezza in capo a individui per oltre 10mila miliardi di dollari, e non sono tutti oligarchi. Oltre mille miliardi sono invece i profitti trasferiti e accumulati dalle multinazionali per via di società fittizie o domiciliazioni di facciata.
Il dramma ucraino, così come per i combustibili fossili, può rappresentare un momento di svolta. Se lo augurano l’European network on debt and development (Eurodad) e la Global alliance for tax justice (Gatj), che il 10 marzo di quest’anno hanno lanciato la proposta della società civile di una Convenzione delle Nazioni Unite sulle questioni fiscali. Segue il modello di altre tre Convenzioni determinanti: quella relativa alla lotta al cambiamento climatico (del 1992), quella che si occupa della protezione dell’ozonosfera (2019) e quella sul controllo del consumo di tabacco (2003).
“Abbiamo trascorso decadi a corteggiare ricchi dittatori, evasori fiscali e organizzazioni criminali, garantendo loro il segreto bancario” – Tax Justice Network
Nel preambolo della proposta di Eurodad e Gatj si riconosce che “gli impatti dell’evasione fiscale internazionale delle imprese danneggiano tutti i Paesi e che le conseguenze sono particolarmente devastanti per i Paesi a basso reddito”. Si riporta la questione fiscale in mano all’Onu, dopo che per anni l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), ovvero il club dei Paesi ricchi, ha ostacolato qualsiasi avanzamento significativo. E racchiude quello che Tax Justice Network chiama l’Abc della giustizia fiscale, ovvero tre misure di trasparenza: lo scambio automatico di informazioni (automatic exchange of information), la registrazione della proprietà effettiva (beneficial ownership registration) e la rendicontazione dei dati nazionali Paese per Paese (country-by-country reporting). “Dobbiamo riprogrammare il sistema finanziario globale per proteggere il benessere e i mezzi di sussistenza delle persone al posto di proteggere i ricchi nell’ombra -ha detto Alex Cobham, direttore esecutivo di Tjn-. Una Convenzione fiscale delle Nazioni Unite in questi termini rappresenta la migliore possibilità al mondo di porre fine alla proprietà anonima della ricchezza, e con essa gran parte dell’abuso fiscale, della corruzione e della disuguaglianza”.
Un’economia di pace passa anche attraverso la cancellazione di uno scandalo europeo troppo poco dibattuto. Quello dei “passaporti d’oro” rilasciati a facoltosi che possono acquistare cittadinanza o residenza in cambio di investimenti nel Paese. Programmi di Citizenship by investment (Cbi), cioè “fenomeni di parassitismo” per i parlamentari europei, sono in vigore a Malta, a Cipro, in Bulgaria. Quelli di Residence by investment (Rbi) in 12 Paesi dell’Ue, con importi e opzioni differenziate. Il 9 marzo il Parlamento europeo ha invitato di nuovo la Commissione a intervenire. Dal 2011 al 2019 oltre 130mila persone ne hanno approfittato. E l’Europa dei muri le ha accolte a braccia aperte.
© riproduzione riservata